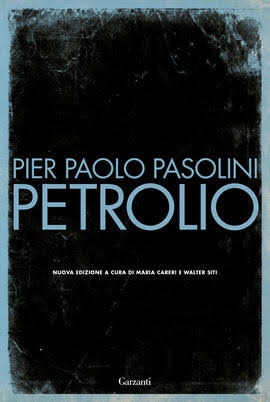“Egli disse: Il seminatore uscì a seminare. E mentre egli seminava, una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un’altra parte cadde in un luogo sassoso, dove non c’era molta terra e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma, spuntato il sole, subito bruciò e non avendo radici si seccò. Un’altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sulla terra buona e diede il frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta. Chi ha orecchi, intenda.” ( Vangelo di Matteo (13: 3-9 / 18-23).
La civiltà ebbe inizio quando l’uomo, per la prima volta, scavò la terra e vi depose un seme. In quel gesto originario era contenuto tutto: la fiducia, il tempo, la possibilità del domani. Oggi, invece, sembriamo vivere sospesi su una cuspide, un punto instabile tra ciò che eravamo e ciò che non sappiamo ancora diventare.

Non è una crisi economica, né un semplice conflitto politico: è un’incrinatura profonda dell’essere umano. Una crepa che attraversa l’anima delle nazioni e i sistemi di potere, la cui mappa ormai non coincide più con i confini tracciati sulle carte. L’Occidente, che per secoli ha fondato la propria egemonia sulla certezza del progresso, scopre di non sapere più che cosa significhi avanzare. Si è smarrito il senso della direzione, come se la storia stessa avesse perso il proprio nord.
Sotto la superficie della geopolitica si consuma un’altra guerra invisibile ma onnipresente tra due concezioni dell’uomo: da una parte i progressisti, convinti che la tecnologia e i diritti possano risolvere ogni frattura; dall’altra i conservatori, che tentano di trattenere un ordine simbolico ormai in disfacimento. È un conflitto che non si combatte solo nei parlamenti o nei mercati, ma anche nelle chiese, nei media, nelle coscienze individuali. Ogni campo, religioso o laico che sia, riflette la stessa tensione: quella tra l’idea di un uomo “costruibile” e quella di un uomo “ricevuto”, depositario di un senso che non può autogenerarsi.

Viviamo in un tempo che scambia la connessione per comunione, la libertà per assenza di legami, la parola per rumore. Ci illudiamo di essere parte di un sistema globale che ci include, quando in realtà ci separa con la precisione di un algoritmo. Abbiamo sostituito il pensiero lento con la reazione istantanea, la profondità con l’immediatezza. Eppure, proprio come le piante che sopravvivono adattandosi senza muoversi, anche l’uomo è chiamato oggi a una forma nuova di radicamento: non più nella materia, ma nella consapevolezza.
La crepa che si è aperta non è una condanna, ma un varco. È da lì che filtra la luce, anche se abbaglia. Ogni civiltà giunge a un punto in cui deve scegliere se continuare a riparare le proprie macerie o imparare a costruire di nuovo. L’Occidente è a quel punto adesso: stretto tra il ricordo della sua grandezza e la paura di non avere più nulla da offrire.
Non possiamo più continuare a vivere di rimandi e di alibi. L’uomo ha edificato muri altissimi per difendersi da se stesso: economici, morali, ideologici. Ma nessuna architettura del potere potrà salvarlo se non tornerà a riconoscersi come seme, e non come radice morta. Perché ogni sistema politico, spirituale o economico si ammala quando l’uomo dimentica di essere parte della vita e non il suo padrone.

Forse non esiste una direzione certa, ma la certezza è ciò che più ci imprigiona. Siamo nell’epoca della cuspide: non possiamo tornare indietro, ma non sappiamo ancora dove mettere piede. È in questa vertigine che si misura il coraggio del nostro tempo non nel vincere, ma nel cominciare finalmente a comprendere.